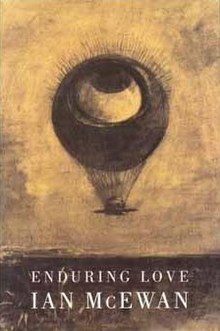Exceptionnellement, je présent un article de Giorgio Ruffolo (L'Espresso 28 settembre 2008) qui décrit bien la situation économique et politique actuelle.
Fino a qualche tempo fa l'attenzione degli economisti era attratta dalla estensione della povertà. Da qualche tempo, l'interesse si è spostato invece sui ricchi. Anzi, sui ricchissimi. Non è voyeurismo. Si tratta di sapere in che tipo di società viviamo e come si esce dalla situazione attuale della crisi del capitalismo. Il posto occupato dai ricchissimi non ha molto a che fare con tutto ciò. Uno dei lavori più recensiti, in America, è quello di David Rothkopf, personaggio eminente sia nel campo degli studi sociali, sia, soprattutto, negli ambienti politici, È stato vicino a Clinton e a Rockefeller. Il suo ultimo libro, "Superclass" (Mondadori), continua a fare rumore, anche perché è con super ricchi (dice che sono seimila circa), i protagonisti del suo testo, che chi oggi pensa di rifondare il capitalismo, dovrà fare i conti. Rothkopf li incontra a Davos, dove si aggirano le ombre della montagna incantata di Thomas Mann: il fascino della signora Chauchat, la pudica malinconia di Hans Castorp. Ce li presenta in uno di quei mondanissimi convegni annuali che sembrano (sembravano) dare indirizzo e razionalità alla globalizzazione. (...). C'è una una sola fede: incrollabile, come quella dei templari, o dei massoni, la fede nel supercapitalismo, liberato da ogni vincolo nazionale e da ogni preoccupazione sociale. Ciò che distingue il nostro tempo infatti non è resistenza di élites nazionali, ma la presenza di una élite sciolta da legami di terra e di sangue, librata in una "candida rosa" al di sopra dei governi, degli Stati, delle nazioni. Una élite vera, nel senso della capacità di governo? E lecito nutrire qualche dubbio, dal momento che fino a poco fa molti di loro, alla testa di banche, erano ignari della spazzatura che si era accumulata nei loro forzieri. Viene il dubbio che non si tratti di una élite e di un governo mondiale ma di un ceto di mandarini privilegiati e irresponsabili: una "schiuma". I loro stipendi eguagliano i redditi di intere nazioni. Non si dovrebbero neppure chiamare stipendi perché non appartengono alla categoria del lavoro e neppure a quella del capitale, ma della rendita (di posizione). Un giorno si dovrà fare il bilancio di quanto è costato alla comunità mondiale questo capitalismo finanziario che ha generato questa plutocrazia irresponsabile. Si dovrà fare il confronto tra il capitalismo regolato degli anni Cinquanta e Sessanta, gli anni del compromesso socialdemocratico, l'età dell'oro, quando una forte crescita si accompagnava con la riduzione delle disuguaglianze; e il capitalismo finanziario generato tra la fine degli anni Settanta e rinizio degli Ottanta dalla decisione strategica del duo Thatcher-Reagan, di liberalizzare i movimenti di capitale. Sono queste le decisioni di governo, non le conferenze di Davos, che hanno segnato la mercatizzazione mondiale dello spazio (globalizzazione) e del tempo (finanziarizzazione). Il fallimento del mercato non si rivela infatti nelle Borse che vanno a picco ma nell'incapacità di generare una economia sostenibile ambientalmente ed equa socialmente. Ma è un fallimento che mette a rischio anche la democrazia. E forse è questa la vera sfida del prossimo futuro. Stiamo parlando dell'aumento della potenza delle corporation rispetto agli Stati nazionali. Nel 2007 il prodotto lordo mondiale era stimato in 47 trilioni di dollari. Le vendite delle prime 250 imprese multinazionali ammontavano a 15 trilioni. Di quelle 250 macroimprese le prime cinque contavano più del prodotto totale di duecento Stati del mondo. Prendiamo gli Stati con più di 50 miliardi di dollari di prodotto nazionale lordo e le imprese con più di 50 miliardi di dollari di vendite. I primi sono 60, le altre 166. Come indici approssimativi del loro potere mondiale le cifre parlano chiaro. La potenza del mondo si concentra in pochi soggetti privati, politicamente irresponsabili; ma decisivi quanto alla selezione dei candidati alle elezioni dei paesi democraticatici. Qui si innesta l'aspetto decisivo dello slittamento dai potere dagli Stati alle corporation: non solo l'enorme flusso di denaro che da queste si riversa sulla classe politica nelle forme del finanziamento illegale, ma sempre più in quelle ormai aperte dei giganteschi contributi elettorali. Quello che era una volta il mercato furtivo delle tangenti è diventato l'acquisto all'ingrosso dei candidati e dei partiti in occasione delle contribuzioni alle elezioni presidenziali e parlamentari, perfettamente legali. All'afflusso del denaro si aggiunge la pressione lobbistica. Dal 1975 al 2005 il numero dei lobbisti registrato a Washington è passato da 3.400 a 33.000. Nel 2005 gli uffici della Commissione europea di Bruxelles ospitavano diecimila lobbisti. E le pressioni non hanno bisogno di essere esercitate illegalmente, perché ogni atto politico, anche il più banale, come un appuntamento, ha un prezzo di mercato. (...). La pubblicità è il più formidabile strumento in mano alle grandi corporation per sostenere il loro potere. È uno strumento sostanzialmente politico, in quanto comanda l'allocazione delle risorse attraverso l'asimmetria dell'informazione. L'ammontare mondiale delle spese pubblicitarie è stimato in oltre 500 miliardi di dollari, circa l’1,3 % del prodotto lordo mondiale, e più di sette volte la spesa destinata alla ricerca sanitaria (70 miliardi di dollari). Maggiore del budget militare degli Stati Uniti (425 miliardi di dollari). (...) Ma che cosa resta della democrazia, se i poteri irresponsabili delle multinazionali surclassano gli Stati nel controllo delle risorse; se sono in grado di controllare le fonti delle decisioni politiche attraverso il lobbismo sistematico; se sono in grado di orientare i flussi della domanda verso la loro offerta di beni (e di mali) privati, deprimendo l'offerta di beni sociali? Lo spazio delle decisioni basate sulla partecipazione e sul consenso dei cittadini si restringe implacabilmente, mentre si amplia quello basato sulle decisioni di consumo largamente influenzate dalle scelte di investimento delle grandi corporation. A Davos, in quella montagna disincantata, non c'è più traccia dellajpudica malinconia di Hans Castorp e del sorriso affascinante della signora Chauchat. C'è solo il vocìo profano dei ricchissimi che si complimentano rassicurandosi reciprocamente. Fino a che qualcuno non oserà a sfidarli.